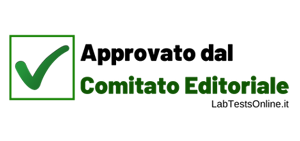Elettroliti
In Sintesi
Perché?
Per rilevare eventuali alterazioni dell'equilibrio elettrolitico dell’organismo.
Quando?
Come parte degli esami di primo livello eseguiti routinariamente o nel caso in cui il clinico sospetti la presenza di un’alterazione dell’equilibrio degli elettroliti (di solito sodio o potassio) o uno squilibrio acido-base.
Il campione
Un campione di sangue prelevato da una vena del braccio.
La preparazione
No, nessuna.
L'Esame
Gli elettroliti sono minerali presenti nei tessuti e nel sangue sotto forma di sali disciolti. Si tratta di particelle cariche elettricamente che permettono l’ingresso delle sostanze nutritive all’interno della cellula e la fuoriuscita dei prodotti di rifiuto all’esterno; sono inoltre implicate nel mantenimento dell’equilibrio idrico e nella stabilizzazione del livello acido/base (pH) dell’organismo.
Il pannello elettrolitico misura i livelli ematici dei principali elettroliti nell’organismo:
- Sodio— un elettrolita carico positivamente; la maggior parte si trova nel liquido presente all'esterno delle cellule e contribuisce a regolare l’equilibrio idrico dell’organismo e promuovere l'attività nervosa e muscolare.
- Potassio— questo elettrolita carico positivamente si trova principalmente all'interno delle cellule dell’organismo. Nel plasma, la parte liquida del sangue, è contenuta una piccola ma essenziale quantità di potassio che svolge un ruolo importante nella regolazione della contrazione muscolare. Il monitoraggio del potassio è importante poiché piccole variazioni nella concentrazione di potassio possono influenzare il ritmo cardiaco e la capacità di contrazione.
- Cloruro— questo elettrolita carico negativamente si sposta tra l’interno e l’esterno dalle cellule per contribuire a mantenere la neutralità elettrica (le concentrazioni dei cationi, carichi positivamente, e degli anioni, carichi negativamente, devono essere uguali) e il suo livello di solito rispecchia quello del sodio. A causa della sua stretta associazione con il sodio, il cloruro contribuisce anche a regolare la distribuzione dell’acqua nell’organismo.
- Bicarbonato— il principale compito del bicarbonato (o CO2 totale, una stima del bicarbonato), che viene rilasciato e riassorbito dai reni, è quello di contribuire al mantenimento di un livello stabile di pH (equilibrio acido-base) e, secondariamente, al mantenimento della neutralità elettrica. Il bicarbonato inoltre svolge un ruolo importante nel trasporto della CO2: gran parte della CO2 prodotta dai tessuti viene trasportata nel sangue sotto forma di bicarbonato verso i polmoni, dove viene espirata.
I cibi assunti forniscono all’organismo il sodio, potassio e cloruro di cui ha bisogno. I reni contribuiscono a mantenere adeguati i loro livelli tramite il riassorbimento o l’eliminazione nell'urina. I polmoni forniscono l’ossigeno e regolano la CO2. Questa è prodotta dall’organismo ed è in equilibrio con il bicarbonato. Il bilancio complessivo di queste sostanze è un indice del corretto funzionamento di diverse funzioni fondamentali. Queste sostanze sono importanti nel mantenimento di vasta gamma di funzioni, tra cui la contrazione del cuore e dei muscoli scheletrici e la trasmissione dei segnali nervosi.
Qualsiasi malattia o condizione clinica che influenzi la quantità di liquido nell’organismo, come la disidratazione, o che colpisca i polmoni, i reni, il metabolismo o la respirazione ha la capacità di causare uno squilibrio dei liquidi, degli elettroliti o del pH (acidosi o alcalosi). Un pH normale deve essere mantenuto entro un intervallo ristretto di valori (7,35-7,45) e gli elettroliti devono essere in equilibrio per garantire il corretto funzionamento dei processi metabolici e la fornitura della corretta quantità di ossigeno ai tessuti. (Per ulteriori informazioni al riguardo, consultare gli articoli relativi a Acidosi e Alcalosi e Disidratazione)
Un parametro correlato è il gap anionico, un valore calcolato utilizzando i risultati del pannello elettrolitico. Esso riflette la differenza tra gli ioni carichi positivamente (chiamati cationi) e gli ioni carichi negativamente (chiamati anioni). Un gap anionico anormale è aspecifico - non diagnostica una specifica malattia o patologia - ma può suggerire la presenza di alcuni tipi di disturbi metabolici o respiratori o la presenza di sostanze tossiche. Per ulteriori informazioni sul gap anionico, vedere la sezione "Domande Frequenti" di seguito.
Nonostante il sodio, il potassio, il cloruro e il bicarbonato siano comunemente misurati insieme come pannello elettrolitico, essi possono anche essere prescritti singolarmente per la diagnosi/monitoraggio delle condizioni che influenzano specifici elettroliti. L’organismo contiene anche altri elettroliti che non fanno parte del classico "pannello degli elettroliti" ma che possono anche essere prescritti dal clinico. Questi includono: calcio (Ca2+), magnesio (Mg2+) e fosfato (PO43-).
Come e Perchè
Il pannello elettrolitico viene utilizzato per identificare uno squilibrio elettrolitico, del volume dei liquidi corporei o del pH (acidosi o alcalosi). Viene spesso prescritto come parte di un’indagine di routine. La misura degli elettroliti può essere utilizzata per studiare le condizioni cliniche responsabili di squilibri elettrolitici come disidratazione, malattie renali, malattie polmonari o patologie cardiache. La misura degli elettroliti può essere utilizzata anche per monitorare il trattamento della patologia responsabile dello squilibrio.
Poiché gli squilibri elettrolitici e acido-base possono manifestarsi in presenza di un'ampia varietà di patologie acute e croniche, gli elettroliti vengono spesso utilizzati per valutare sia i pazienti che afferiscono al pronto soccorso sia quelli ricoverati.
I risultati di un pannello elettrolitico possono includere anche un calcolo del gap anionico, utile per contribuire a rilevare condizioni patologiche o la presenza di sostanze tossiche (vedi sotto).
Se è presente lo squilibrio di un singolo elettrolita, come sodio o potassio, possono essere prescritte analisi ripetute di quel singolo elettrolita, monitorando lo squilibrio fino alla sua scomparsa. Se è presente uno squilibrio acido-base, può essere prescritta anche un’emogasanalisi. Questa fornisce i valori del pH, dell’ossigeno e dell’anidride carbonica in un campione di sangue arterioso, per contribuire a valutare la gravità dello squilibrio e monitorare la risposta al trattamento.
Domande Frequenti
I risultati sono interpretati dal clinico nel contesto di altri esami che sono stati effettuati e di altri fattori, come la storia clinica. Un singolo risultato leggermente alto o basso può avere o meno significato clinico. Esistono diversi motivi per cui il risultato di un test può variare in giorni diversi e per cui potrebbe non rientrare nell’intervallo di riferimento.
- Variabilità biologica intra-individuo (risultati diversi nella stessa persona in momenti diversi): un esame effettuato sulla stessa persona in occasioni diverse può, per motivi biologici, non rientrare negli intervalli di riferimento anche in assenza di patologie.
- Variabilità biologica tra individui (differenze nei risultati tra persone diverse): gli intervalli di riferimento sono generalmente calcolati raccogliendo risultati da una vasta popolazione, valutandone la distribuzione in modo da includere il 95% dei soggetti. .Ci sono persone che sono in buona salute ma i cui risultati, che sono normali per loro, non rientrano mai nell'intervallo atteso della popolazione complessiva.
Pertanto, il valore di un esame che non rientra nell'intervallo di riferimento stabilito potrebbe non avere significato clinico. In genere, questo avviene qualora un risultato sia solo leggermente superiore o inferiore all'intervallo di riferimento. In queste situazioni spesso viene richiesta la ripetizione dell'esame e viene valutato l'andamento dei risultati precedenti.
Tuttavia, un risultato al di fuori dell'intervallo può indicare un problema e giustificare ulteriori accertamenti. L'operatore sanitario valuta i risultati degli esami nel contesto della storia clinica, dell’esame fisico e di altri fattori rilevanti per valutare il significato clinico di un risultato anomalo. Per ulteriori informazioni, si rimanda all'articolo Gli intervalli di riferimento ed il loro significato.
Pagine Correlate
Fonti
2019 review performed by Kenneth A. Wong, BSc (MLS), MLT, Instructor, NAIT and the Editorial Review Board.
Rifai, N. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. [Pageburstls]. Retrieved from https://pageburstls.elsevier.com/#/books/9780323359214/
Larson, D. Clinical Chemistry: Fundamentals and Laboratory Techniques. [Pageburstls]. Retrieved from https://pageburstls.elsevier.com/#/books/9781455742141/
Lewis J, Water and Sodium Balance, Merck Manual. Available online at https://www.merckmanuals.com/en-ca/professional/endocrine-and-metabolic-disorders/fluid-metabolism/water-and-sodium-balance. Accessed 7/17/19.
Electrolyte Disorders. Merck Manual. Available online at https://www.merckmanuals.com/en-ca/professional/endocrine-and-metabolic-disorders/electrolyte-disorders. Accessed 7/17/19.